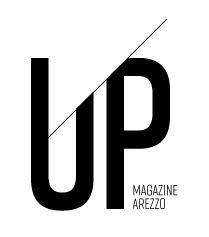Cristiano Cini per tutti gli aretini, e oltre, è il vino. Non solo per le cariche ricoperte all’interno dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) ma per un’esperienza quasi trentennale in questo mondo, per i progetti che ha saputo realizzare nel tempo, non ultimo Wine TV (Canale Sky 815), per come racconta il vino e il suo approccio a un mondo che piano piano è diventato il suo. Dove ‘piano piano’ è il tempo della natura, l’attesa, il lavoro, il rispetto di ciò che non si può forzare, il piacere del risultato finale. Cristiano, classe ’71, si è diplomato ragioniere per poi seguire le orme familiari nello storico (dal 1932) ristorante (arrivato oggi alla quarta generazione e gestito dalla sorella Caterina) di famiglia: «Ero uscito dal serale, lavoravo qui, ma ancora non mi si era accesa la lampadina. Fu mia madre a dirmi di studiare il vino, che dovevo conoscerlo e che questo sarebbe stato importante per il nostro mestiere. Praticavo anche pentathlon moderno ma ancora non avevo preso niente sul serio. Mi sono iscritto al primo corso AIS e ho scoperto un ambiente che non ha acceso solo la lampadina, ma tutte le sinapsi della mia curiosità, è stato fondamentale. Ho trovato insegnanti che mi hanno saputo trasmettere delle emozioni, che hanno attirato la mia attenzione più profonda e così, per la prima volta in vita mia, mi sono messo a studiare profondamente un argomento. Sono passati venticinque anni e ancora non ho smesso, perché mi sono appassionato visceralmente al vino e a tutto ciò che lo circonda». Ha incontrato e avuto come primo vero maestro Silvio Peri, il quale insieme con Giorgio Pinchiorri ha fatto la storia della sommellerie in Italia: «È grazie pure a questi incontri che ho allargato la mia visuale. Oggi sono consulente di alcune aziende, amici con i quali condivido la stessa visione del vino e della sua produzione. Mi confronto con l’enologo, l’agronomo, seguo la parte tecnica in maniera leggera, mentre sono più presente al momento del racconto, fissarne la narrativa, spiegare come si comunica e come si vende il prodotto finale». E da tutte queste cose insieme è nata la grande idea di Wine TV: «Con Simona, mia moglie (sommelier pluripremiata, ndr), tante volte ci siamo confrontati su come raccontare il vino su larga scala, su come raggiungere una massa critica importante di persone, con il giusto linguaggio, per farla emozionare raccontandogli cosa si nasconde dietro un’etichetta, la storia degli uomini che diventa storia del vino che producono. Fino a quel momento il vino e il suo racconto erano altro, da una parte l’alcol, dall’altra un mondo chiuso, quasi elitario, con dei media verticali abbastanza standardizzati. Non era facile, non lo è mai, ma grazie a Cristiano Stocchi e Maurizio Gambini di Atlantide ADV ci siamo messi a tavolino e siamo riusciti a progettare Wine TV». Un progetto che oggi è realtà, la più importante sul vino dal punto di vista televisivo. E solo uno come Cristiano Cini poteva pensarci, perché? Perché per lui il vino è anche sfida, è confrontarsi con sé stesso, è divertimento, è lasciarsi cullare dalla fantasia, studiare senza sosta e rimanere continuamente aperto alle novità. Proprio come quando si sceglie un vino prima di mangiare.

Cosa è stato e cosa è il vino per Cristiano Cini?
«Il vino è stato il modo con il quale ho cambiato l’approccio alla vita. Conoscendo come nasce un vino, un grande vino come quello di territorio, comprendi molte cose. Comprendi che ci sono i tempi della natura e che alcuna accelerazione è possibile. Allora capisci che c’è un altro modo di vivere e divertirsi e io quei ritmi li ho portati sempre con me, in tutto ciò che faccio e che ho fatto: dal ristorante all’AIS. I tempi per un vino sono fondamentali, è un progetto in continuo divenire e più che correre dietro devi fare un passo indietro per seguirlo bene. Oggi il vino è la mia vita sotto tutti gli aspetti: mi appaga, mi gratifica, mi spinge a continuare a studiare. Anche questo è un grande insegnamento. Si scoprono nuove tecniche, nuovi territori e questo mi fa stare sempre acceso: è il mio produttore naturale di entusiasmo per affrontare ogni giorno su questa terra».
Da neofiti l’impressione è che la produzione vitivinicola italiana in questi ultimi vent’anni abbia scelto la via della qualità oltre che della quantità? Se sì, dettata da quali fattori?
«È così. La scelta della qualità è una strada a senso unico, definitiva. Oggi è difficile, oserei dire impossibile trovare un vino italiano che non sia buono, cioè che non sia ben fatto. Dove qualità fa rima con unicità, del territorio, della regione. Poi su ottanta persone a quaranta piace e a quaranta no, ma è una questione di gusto personale. Cosa resta? Resta la qualità della produzione che in Italia richiama l’identità del prodotto. Inutile concorrere contro i vini argentini, australiani e cileni, per esempio, sul prezzo. Inoltre questa scelta ha educato il consumatore, ne ha innalzato il livello, il quale sceglie e continuerà a scegliere la qualità al giusto prezzo; continuando ad assaggiare cose diverse e acquisendo un gusto sempre più definito».
Restando sull’argomento, quanto è stato grave lo scandalo metanolo per il vino italiano e la sua immagine, in patria e all’estero?
«È stata la chiave di volta. Ha rivoluzionato, per primo, il regime del Chianti Classico, che è diventato sempre più selettivo e con il tempo, dal punto di vista del consumatore, inclusivo. Il mercato è stato trainato da alcune élite, poi ci ha pensato la diversità. Ogni cinque, dieci, chilometri, cambia il terreno e quindi anche il vino e nessuno al mondo ha questa caratteristica, che si è affinata con nuove tecniche e una vera cultura del vino».
Negli ultimi tempi si parla molto di cultura italiana del vino, in cosa consiste?
«È un discorso complesso che comprende più leve. Prima di tutto, noi italiani siamo legati al vino, fa parte del nostro vissuto, familiare e sociale, un rapporto viscerale che pochi altri popoli possono vantare. Questo è il primo tassello, trasversale, di questa ‘cultura’. La seconda leva è stata il Made in Italy, quando si è compresa la ricchezza, storica, culturale ed economica che il vino porta con sé, diventando un settore fondamentale della nostra economia. Non deve essere visto solamente come un argomento di consumo, è qualcosa di più profondo, qualcosa che abbiamo dentro, è radicato dentro di noi. Poi c’è lo studio che ci ha permesso di fare diventare tutto questo qualcosa di unico e, se vogliamo, patinato. Il mondo della sommellerie, per esempio, storicamente è fatto da Francia e Italia, ma noi siamo più preparati, sappiamo raccontare meglio la nostra storia. L’AIS (Associazione Italiana Sommelier) non è una figura ‘arrogante’, bensì di supporto al vino italiano, vive il territorio, lo calpesta, conosce i produttori. Siamo stati i primi a raccontare il connubio tra cibo e vino, valorizzando entrambi. Non siamo gli eruditi che non si fanno comprendere e abbiamo creato una massa critica di intenditori e appassionati che fa parte del sistema Italia, è una cultura integrata».
Si dice che un vino oggi lo fa l’enologo, in che misura è vero?
«Se avessi una mia azienda vitivinicola mi ritirerei, lo considererei un sogno, un punto di arrivo. Se ce l’avessi e non fossi capace di mandarla avanti se non con l’aiuto dell’enologo, avrei fallito, sarebbe come possedere una macchina e non saperla mettere in moto. Abbiamo vissuto un quindicennio in cui l’enologo era il protagonista del vino, con il suo entourage, capace di dare visibilità e posizionamento al prodotto. Oggi non funziona più così, oggi l’enologo è al servizio della proprietà, è il membro di una squadra che deve produrre un vino, innanzi tutto pulito, con una sua identità e una sua espressività».
Cosa è e cosa fa l’Associazione Italiana Sommelier?
«Da presidente toscano a responsabile dell’area concorsi AIS Italia, è la mia vita. È stata mia madre a spingermi perché non sapevo niente di vino, mi sono guardato intorno e ho scelto l’AIS, ed è stato il motore per tutto quello che ho fatto dopo. Abbiamo formato tre milioni di persone nel mondo e non parlo solo di sommelier e di cultura del vino. Perché le cose cambiano e noi con loro, ogni vent’anni ci sono nuovi obiettivi da raggiungere. Il primo è stato la consapevolezza di saper raccontare il vino, anche dal punto di vista editoriale. Il secondo è stato rinnovarsi, comprendere come la professione del sommelier non fosse solo quella di consigliare il vino, ma anche di comunicarlo, amministrarlo e gestirlo, a trecentosessanta gradi. Oggi, per esempio, la figura del sommelier può essere quella di un dirigente che gestisce la cantina di un resort nei Caraibi, parlando più lingue. L’AIS è stata portatrice sana di questo grande cambiamento».
Quanti soci ha in Italia e ad Arezzo?
«Prima del Covid-19 ne contavamo 41.700 in Italia e 4.100 in Toscana, di cui il dieci per cento ad Arezzo. E nonostante tutto quello che sento dire esiste un sistema Arezzo, grazie anche all’AIS, un sistema che, rispetto al passato, è cresciuto molto con connessioni forti tra sommelier e cuochi, tra chi racconta il vino, l’olio, e chi lo comunica, tra privati, associazioni e istituzioni. Un sistema che, tutto insieme, racconta la nostra terra, senza contare quanti campioni sono usciti dall’AIS aretina. Arezzo è conosciuta nel mondo grazie a tante persone lungimiranti che hanno avuto il coraggio e l’intelligenza di andare oltre il proprio orticello, riuscendo a fare vera sinergia».

Quali sono le tre caratteristiche principali che fanno di un vino un ottimo prodotto?
«L’unicità. Non deve essere ripetibile né omologabile. La precisione, tecnica e pulizia, altrimenti non hai fatto bene il tuo mestiere. Infine la bevibilità (o beva, ndr), che è un elemento soggettivo. Questo, comunque, si ottiene con un approccio facile alla bottiglia, tra cifra tecnica e quella stilistica. Tra i sommelier vale la massima che il vino più buono è quello che, a tavola, finisce prima degli altri. Puoi avere dieci grandi vini, ma vince quello che riesci a bere, a raccontare meglio, quello che è più facile approcciare e comprendere».
Quando andiamo al ristorante ci dobbiamo fare consigliare o è meglio arrivare con le idee chiare? E in questo caso cosa dobbiamo sapere per scegliere bene?
«Valgono entrambe le cose. Dipende di cosa abbiamo voglia quel giorno e di cosa abbiamo voglia rispetto a ciò che decidiamo di mangiare. È importante avere le idee chiare così come avere una mentalità aperta e fidarsi del ristoratore, il quale mi racconta tre, quattro, cose e poi scelgo io. Chi racconta deve mettermi nelle condizioni di scegliere bene e magari spingermi ad assaggiare cose nuove. Non basterebbero tre vite per scoprire tutto quello che di nuovo c’è nel vino. A volte, però, vuoi andare in profondità, rispetto a un vino o a un vitigno. Ti devi anche fidare in modo che alla fine la scelta sia un divertimento e non uno stress».
Negli ultimi anni le bollicine hanno preso il sopravvento di un certo tipo di bere? Perché è una bevuta più facile? O è solo uno dei tanti luoghi comuni sul vino?
«È un luogo comune. È chiaro che un Prosecco, per esempio, nell’immaginario collettivo rappresenti la bevuta facile, senza pensieri. Non ti aspetti niente di complicato, non c’è freno alla beva, e la temperatura fresca aiuta. Lo stesso Pinot nero non spumantizzato, però, si può bere fresco. Perché nel vino, come nella vita, i concetti che appaiono semplici hanno tutti una loro complessità. Nel tempo le bollicine hanno smesso, però, di essere accostate esclusivamente all’idea di aperitivo. Con la bolla puoi mangiare tutto, dall’inizio a fine pasto, considerando le nostre produzioni italiane, dal Trento D.O.C. al Franciacorta. La base della bolla in metodo classico, ad esempio, è variabile e può incontrare gusti diversi: se ti piace uno spumante strutturato sarà proprio il Pinot nero quello che cerchi, se invece cerchi eleganza e freschezza devi provare una base Chardonnay. C’è uno spumante per ogni gusto, basta cercare quello che si addice di più al tuo palato. Il consumo delle bollicine è in crescita e non conosce stagione, così come regione, visto che ne nascono di continuo da vitigni autoctoni in ogni angolo d’Italia, oltre quelle che già conosciamo».
Il vino buono deve costare molto o è solamente l’immagine riflessa che abbiamo di un certo mondo?
«L’idea che il vino buono debba costare molto è lo specchio del mondo in cui viviamo. Prendiamo il Brunello di Montalcino, ci sono brand diversi e prezzi differenti, ma già a 30 euro a bottiglia puoi bere bene, divertendoti. I francesi hanno classificato il Bordeaux nel 1885 e l’hanno cambiato una sola volta spostando un singolo vino, nel 1973. È una classificazione così precisa e chiara che funziona perfettamente, ci sono diverse categorie di vino, da 1 a 5, che corrispondono a qualità e prezzo diversi; le aziende di prima fascia sono il top quindi sono di qualità e costo più alti. È da subito chiaro al consumatore cosa scegliere. Così si aiuta l’acquisto. Oggi possiamo dire che esiste una soglia minima: 4,50 euro per una bottiglia di vetro è il limite sotto il quale non si può scendere. Poi, senza brand, si beve bene un vino da dieci, come da quindici, benissimo uno da venti euro. Anche questo fa parte dell’educazione al vino e alla sua cultura».
Il vino oggi è anche investimento. Come si può investire e attraverso quali strumenti?
«Investire nel vino non è come investire in un’azienda quotata in Borsa, cercando un profitto. Esistono fondi d’investimento legati ai grandi vini, dove si può guadagnare o essere pagati direttamente con il prodotto, ma serva una base economica importante. Così come comprare grandi prodotti, tenerli per una decina d’anni e poi rivenderli, ma non è facile e il rischio di questo tipo d’investimenti è sempre alto, soprattutto se non hai una profonda conoscenza del mondo del vino. Pensiamo al Barolo, posso acquisire un’azienda già avviata, ma ci vogliono tanti soldi, oppure un’altra in una zona meno vocata e partire da zero. Nel secondo caso, un imprenditore che compra la terra e pianta i vigneti per diventare un produttore prima di cinque anni minimo non vede un soldo, non vede il ritorno di tutto ciò che ha investito, sia in termini di denaro che di fatica».
L’aperitivo è un modo sbagliato o un modo diverso di bere? Ed esiste l’aperitivo di qualità?
«L’aperitivo è una forma di intrattenimento e di condivisione, ci si rilassa tra amici, senza pensieri. Ma bere solo per bere non ha senso, non fa parte di quella cultura che noi divulghiamo. Il nostro principio è diverso. Mi prendo trenta minuti, chiacchiero con un amico, magari in quella mezz’ora ho aperto un vino importante, ce lo godiamo in tutta la sua evoluzione e lo ‘assaggiamo’ mentre si racconta. Questa per me è condivisione e credo che bere bene sia la forma migliore di aperitivo che conosca».
Nei giovani pare che ci sia un’incultura del bere. Come si impara a bere, a riconoscere i propri limiti e a consumare prodotti di qualità?
«La qualità, come ci siamo detti, non sta solamente nel prezzo. Ovviamente, tutti abbiamo avuto 16-18 anni, tutti siamo stati ragazzi e abbiamo affrontato il tema dell’alcol, con le sue fragilità. L’alcol, in realtà, è solo una parte del vino, minima direi. Ci vuole curiosità di assaggiare qualcosa di nuovo, di diverso, l’etichetta che cattura la mia attenzione e magari la leggo, leggo cosa c’è scritto dietro, m’incuriosisce la storia di chi l’ha prodotto, il territorio dove cresce e matura. In questo modo non solo bevo, ma entro dentro un mondo. S’impara a bere accendendo le sinapsi della curiosità e avvicinandosi a un mondo bellissimo, ricco di aneddoti e curiosità. Il primo passo può essere quello di un’etichetta colorata o strana, poi lo versi e guardi cos’è, Pinot nero, Syrah, poi lo assaggi e ti fai delle idee. Così s’inizia a bere consapevolmente».

Con il vino misuriamo spesso i nostri confini, di conoscenza, di gusto e personali. Si può dire: dimmi come bevi e ti dirò chi sei?
«Sì, verissimo. Però per uno che ha fatto del vino il suo approccio alla vita, nel percorso di crescita c’è sempre dietro l’angolo un prodotto nuovo da assaggiare e al quale appassionarsi, soprattutto nei luoghi e nei territori dove meno te lo aspetti. Il gusto personale esiste, ma i confini meno, perché c’è sempre da conoscere cose nuove e da imparare. È il mondo del vino, è fatto così».
Cibo e vino, spesso gli accostamenti sono generici: carne rosso, pesce bianco, ecc. Come si può imparare ad abbinarlo in modo corretto a ciò che mangiamo?
«La cosa più bella è sperimentare. Prendi tre vini diversi, una bolla, un Sangiovese e una Vitoska. Tutti e tre possono essere bevuti con l’antipasto, il primo o il secondo, dipende da tante cose diverse, a partire dal cibo, dalle tecniche di produzione, dalle temperature, ecc. Oramai certi dogmi sono completamente superati. Esempio: quaglia disossata e farcita. Ci abbiniamo un rosso? Forse, ma anche un orange ben fatto. Dobbiamo sperimentare, liberare la fantasia e divertirsi».
Oggi i vini hanno tutti una gradazione alta rispetto al passato. Da cosa dipende e come questo è collegato alla loro qualità?
«Più che l’alcol incide il cambiamento climatico sul tenore alcolico. Oggi produciamo Sangiovese a 650 metri di altezza, in passato no. Le escursioni termiche alzano l’acidità, gli aromi, e abbassano l’alcol nel vino. Oggi ci sono terre dove vengono prodotti vini quando una volta sembrava impossibile. La diga del Bilancino ha creato un microclima adatto al Pinot nero che un tempo non esisteva».
Si dice che Pinot Nero, Riesling e bollicine siano il bere dell’uomo saggio? Cosa c’è di vero o alla fine è solo una questione di gusti personali?
«Gusto personale, che si lega anche al momento, alla mia esperienza, agli amici che fanno lo stesso lavoro. Una volta ci va un Pinot Nero, una volta un Riesling, altre prendiamo dieci Bolgheri e li confrontiamo. Oggi, per esempio, bere il Pinot nero è di moda, anche questo incide».
I cosiddetti Supertuscan hanno segnato un’epoca del vino toscano e italiano, sono ancora sulla cresta dell’onda o qualcosa è cambiato?
«Credo che iniziamo a comprendere adesso il significato dei Supertuscan. Il primo è nato nel 1968 a San Felice, con l’esaltazione del Sangiovese fuori dalle regole. Quando prima nel Chianti era impensabile fare Sangiovese in purezza, significava andare contro le regole, contro il sistema. Negli anni Ottanta, poi, sono arrivati i recensori americani, che hanno esaltato quella scelta dando al Sangiovese un taglio decisamente internazionale, oppure lo hanno proprio escluso a favore degli internazionali Cabernet Sauvignon, Merlot, ecc. Oggi i Supertuscan possono essere sia blend che in purezza e, probabilmente è corretto dire che rappresentano l’essenza del territorio toscano».
L’Italia ha una varietà enorme di viti e di produzioni, una forza che all’estero non si percepisce, come mai?
«Siamo ancora convinti che il cinese, il giapponese o il sudamericano conoscano l’Italia come la conosciamo noi, quando a Shanghai, quindici anni fa ero lì per fare dei seminari sul vino italiano, non sapevano nemmeno dove fosse il nostro Paese. I francesi si sono mossi in gruppo e hanno fatto sistema, da noi qualcuno è convinto che all’estero possano conoscere bene vini come il Barbaresco ed è un atteggiamento arrogante. Piccolo è bello non paga, un conto è la nicchia, un conto il mercato internazionale. C’è tanto lavoro ancora da fare per affermarsi come sistema Italia vitivinicolo».

Perché i vini ‘esotici’ (argentini, cileni, statunitensi, sudafricani, australiani e neozelandesi; spesso prodotti da grandi cantine europee) riscuotono più successo?
«In Australia, per esempio, ci sono poche corporazioni che insieme rappresentano una larga percentuale della produzione totale. Se si muovono assieme, nel loro target, hanno la capacità di conquistare mercati in qualsiasi angolo del mondo. Lo fanno con buoni prodotti e giuste fasce di prezzo. Noi questo non ce l’abbiamo. La nostra capacità di fare rete è ancora in costruzione e questo, a livello globale, ci manca».
Sta avanzando anche il vino cinese (con importanti investimenti europei), con quali prospettive?
«Sono pericolosi e vanno tenuti d’occhio. Non hanno la nostra vocazione e non ce l’avranno mai, come si fa a parlare di territorio per un Paese così grande; già territorio è un concetto alto per il consumatore della domenica, figuriamoci se la qualità cinese costa quanto quella italiana. In Cina sono arrivati i francesi, hanno costruito gli chateau, fanno i blend in stile francese, con prezzi vergognosamente alti. Il pericolo vero è che, alla fine, invadano il mercato con prezzi bassi, facendo una cattiva concorrenza al resto del mondo, Italia compresa. Noi abbiamo le grandi aziende, ma al tempo stesso una grande varietà regionale rispettata anche dalle stesse grandi aziende, che in futuro ci darà sempre più soddisfazioni: diversificare la qualità, questa è la nostra arma vincente».
Quanto è importante il terroir per la qualità di un vino?
«Il terroir è tutto, ma ne va compreso il significato. Ci sono le condizioni del suolo, il clima, il tipo di vitigno o l’insieme dei vitigni, poi c’è l’uomo. È l’uomo che mette insieme tutte queste cose e, senza, il terroir non può esprimersi, non si ottiene quell’unicità di cui abbiamo parlato prima. Non esistono, per esempio, due nebbioli uguali, non accadrà mai nel mondo. Questo è il valore tangibile e insostituibile, la forza, del terroir».
A proposito di territorio, Arezzo una volta non era terra di grandi vini, o così si raccontava. Adesso possiamo invece vantarci di Sangiovese, Syrah e Pinot Nero di alta qualità. Cosa ha provocato questo cambio di marcia?
«Ho fatto due mandati come presidente delle Strade del Vino Terre di Arezzo ed è stata un’esperienza molto importante. Sono stato a contatto con i produttori locali, ho conosciuto persone lungimiranti. Basti pensare ai D’Alessandro con i quali, nel 1987-88, è nato il nostro Syrah. Il Pinot nero in Casentino. Il Sangiovese. Frutto di aziende che hanno saputo aspettare e hanno saputo valorizzare il territorio insieme ai loro prodotti. Oggi abbiamo vini importanti, ottimi prodotti, grande diversità e ricchezza. Basti pensare al Caberlot, frutto di una piccola azienda che ha investito tutto sulla qualità più che sulla quantità».
I vitigni preferiti di Cristiano Cini?
«Due anni fa al Passioni Festival mi chiesero di raccontarmi attraverso tre vini, difficile, molto difficile. Quello che, però, mi rappresenta maggiormente è sicuramente il Sangiovese, sono un ‘sangiovesista’. Diciamo, più umilmente, che mi piace pensare di essere rappresentato, dire che mi rappresenta è un’illusione. Difficile descrivere il perché a parole e con un unico concetto. L’acidità, i tannini sottili, il colore scarico, il tratto all’olfatto, l’eleganza, la scorrevolezza e la grande beva. È il mio vino».