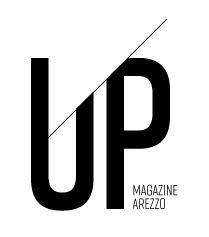Da tessuto rustico per il saio dei frati e le mantelline dei cavalli, a icona della moda italiana nel mondo: una storia che continua a essere scritta

Alzi la mano chi non ha davanti agli occhi l’immagine della divina Audrey Hepburn con indosso il suo cappotto di lana color arancio, mentre entra nella celebre gioielleria newyorkese nella scena cult del film “Colazione da Tiffany” del 1961. Se dovessimo fare un elenco dei prodotti aretini più famosi nel mondo, il cosiddetto panno Casentino sarebbe di certo ai primi posti, non solo per quella iconica sequenza cinematografica.
L’evoluzione del caratteristico tessuto con il “ricciolo” ha una storia lunghissima, che ha inizio in epoca etrusco-romana e prosegue in quella medievale. Dai documenti si sa che nel Trecento gli abitanti di Palagio Fiorentino, l’odierna Stia, pagavano le tasse alla Repubblica Fiorentina usando il cosiddetto “panno grosso”, un tessuto rustico di lana sui toni del grigio che serviva soprattutto per rea- lizzare il saio destinato a monaci e frati.
Nel XVIII secolo sono documentati opifici per la lavorazione della lana di pecora in tutta la valla- ta, in particolare a Soci di Bibbiena e a Stia, che usufruivano delle nuove direttive granducali del 1738 sulla liberalizzazione di questa produzione. Nella seconda metà dell’Ottocento la proverbiale resistenza del panno prodotto in Casentino fu sfruttata a Firenze per commercializzare le mantelline per le cavalcature, ovvero destinate a coprire gli animali da traino nei mesi freddi. Sono gli anni in cui il Lanificio di Soci e il Lanificio di Stia, passando dai telai a mano a quelli meccanici, trasformarono una tradizione tessile artigianale in produzione industriale, andando a connotare per i successivi decenni l’economia dei due luoghi. Il tessuto venne presentato con successo anche alla famosa Esposizione Universale di Parigi del 1889.

L’attività laniera coinvolgeva ormai centinaia di operai e si calcola che tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo i due lanifici assieme davano lavoro a oltre 800 persone. Le operazioni principali per ottenere il panno Casentino erano la “follatura” che lo rendeva impermeabile, la “garzatura” per avere un lato peloso e, dai primi del Novecento, la “rattinatura”, attraverso un apposito macchinario per creare i riccioli, che servivano a rendere il tessuto più resistente all’usura ma che divennero presto uno degli elementi caratteristici, assieme ai colori “arancio becco d’oca” e “verde bandiera”.
Secondo una versione tradizionale l’arancio nacque casualmente per un errore di chi, per impermeabilizzare il tessuto, pensò di unire all’allume di rocca dei coloranti chimici al posto della robbia, pianta dalle cui radici i tintori ricavavano il colore rosso. Venne fuori un rosso aranciato che fu comunque messo nel mercato e trovò un riscontro insperato. Il verde inizialmente venne invece accostato a quello arancio solo come fodera, perché i due colori si abbinavano bene. In seguito divenne anch’esso una delle tinte classiche e più riconoscibili del panno.

Sempre nella seconda metà dell’Ottocento, rendendosi conto che d’inverno stavano peggio dei loro cavalli, i barocciai e i cocchieri fiorentini iniziarono a recuperare le mantelline degli animali per farle cucire assieme e creare cappotti e mantelle sempre più curati. L’idea piacque molto alle signore di Firenze e fu apprezzata anche da figure illustri come il nobile e politico Bettino Ricasoli e i musicisti Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.
L’antico tessuto divenne nel corso del Novecento un’icona del made in Italy, simbolo di eleganza e raffinatezza, indossato da personaggi del mondo della cultura, del cinema, dello spettacolo e della politica. Grandi stilisti come Roberto Cavalli, Pierre Cardin e Gianfranco Ferré lo esportarono nelle piazze della moda di tutto il mondo, decretandone un successo duraturo. Chi produce oggi il panno Casentino continua a guardare al futuro nel segno della ricerca e dell’ampliamento della gamma dei colori e dei modelli, senza mai dimenticarne l’affascinante storia, che può essere ripercorsa anche nel Museo dell’Arte della Lana di Stia, allestito all’interno dell’ex lanificio del XIX secolo, uno degli esempi di archeologia industriale più importanti del territorio aretino.
Nei secoli precedenti nella zona c’erano già delle piccole gualchiere che lavoravano la lana in maniera artigianale, sfruttando l’acqua del torrente Staggia. Alla fine del Settecento nacque un lanificio, che nei primi anni dell’Ottocento crebbe ancora, ma nel 1848 chiuse i battenti. Nel 1852 sorse la Società del Lanificio di Stia, che dopo il 1870 e l’arrivo di moderni macchinari dall’estero giunse ad avere fino a 500 dipendenti.
Nel 1979 chiuse definitivamente i battenti, ma grazie al museo voluto dalla Fondazione “Luigi e Simonetta Lombard”, creata dalla famiglia che per sessant’anni condusse l’industria, quel patrimonio umano e di macchinari che fu il Lanificio di Stia può essere fatto conoscere ai turisti e alle nuove generazioni