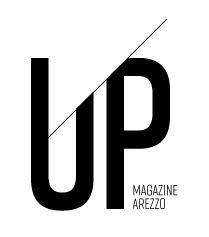Il trionfo della Nazionale agli Europei. La gioia per una vittoria storica. Le feste di piazza. Gli sguardi innamorati davanti ai televisori. I campetti di periferia dove nascono i sogni più belli. E la potenza di uno sport che, nonostante le sue contraddizioni, continua a tirarci fuori le emozioni più spontanee e genuine
Il fatto è che non siamo mai cresciuti. Siamo rimasti questi ragazzini della foto, con le biciclette buttate da una parte, la polvere sotto le scarpe, una porta e un pallone. C’è la felicità in questa immagine, c’è quel groviglio di emozioni che ti avvolge da bambino e non ti lascia più. Nonostante l’età, nonostante i dispiaceri, nonostante le priorità che cambiano, il lavoro, i figli, l’amore, le cose brutte.
Se guardiamo con gli occhi del cuore, non c’è differenza tra Wembley e un campetto di periferia, tra la maglia azzurra di Chiellini e questa un po’ sdrucita con il 21 di Pirlo sulla schiena, magari comprata a una bancarella, qualche anno fa, per pochi spiccioli. Sta qui il fascino eterno e immutabile del calcio, nella sua ciclicità di sentimenti, nella sua capacità di fermare il tempo e ributtarci addosso la gioventù, quando sognavamo a occhi aperti, senza pensieri.
“Tiro forte non vale” dicevamo prima delle partitelle infinite, che si chiudevano solo quando il proprietario del pallone tornava a casa. Erano le sfide a “scattino” che ci facevano crescere, mettendoci di fronte ad avversari più o meno bravi, più o meno grossi, più o meno rudi. E il tiro a giro l’abbiamo inventato noi sulla strada, anche se i pali non c’erano, c’erano i giubbotti ammucchiati per terra e il gol non te lo davano mai.
L’Italia campione d’Europa è la sublimazione delle nostre ambizioni più genuine e spontanee, nascoste ormai sotto strati di subconscio ma sempre in ebollizione, pronte a esplodere con forza, lasciandoci stralunati dall’esultanza.
Dicono che il calcio piaccia in modo trasversale e globalizzato perché è un richiamo ancestrale al nostro passato di cacciatori, quando inseguivamo la preda per sopravvivere. E che piaccia perché dentro c’è qualcosa di mistico, tant’è che si parla di fede, di tempio, di idoli e semidei da venerare. Qualcuno, osando un po’, è arrivato a sostenere perfino che le religioni sono nate perché ancora non esisteva il calcio.
Il grande Dino Buzzati, dopo la tragedia di Superga del 1949 in cui perì il Grande Torino, ebbe a scrivere per il Corriere della Sera: “Avrebbero avuto altrettanto dispiacere i bambini e gli animali semplici di tutta Italia se l’aereo fracassatosi a Superga fosse stato carico di scienziati illustri? No, sia detto sinceramente. E se fosse stato carico di famosi scrittori e poeti, la gente ne avrebbe sofferto altrettanto? Neanche in questo caso se vogliamo essere onesti. Proprio in questa occasione si è misurato e si è capito fino in fondo che cosa possano essere, per la gente senza complicazioni, gli «assi» del calcio. Anche noi, dobbiamo confessarlo, li prendevamo alquanto sotto gamba. Bel merito, saper dare dei calci ad un pallone; val la pena, per una prestazione simile, farne dei superuomini, per essi sgolarsi, smaniare, soffrire, spendere un mucchio di quattrini? Così si pensava molto spesso. E ci voleva la tragedia di Torino per aprirci gli occhi”.
Una riflessione che avrebbe condiviso anche lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, al quale chiesero: “Come spiegherebbe a un bambino cos’è la felicità?”. Lui rispose: “Non gliela spiegherei, gli darei un pallone per farlo giocare”.

Il link con i nostri sogni adolescenziali è più potente della repulsione per il circo dei multimilionari di oggi, la Superlega, il calendario spezzatino, il merchandising esasperato, lo strapotere delle televisioni, la politicizzazione dello sport, le infiltrazioni malavitose tra le tifoserie, lo sprezzo per le tradizioni, la noncuranza del Palazzo verso le categorie minori.
L’Italia che batte l’Austria e il Belgio, che resiste alla Spagna fino a piegarla, che doma i leoni d’Inghilterra nella loro arena, che celebra in mondovisione l’abbraccio fraterno fra Mancini e Vialli, è un concentrato di sentimenti, immagini e significati che trascendono il campo di gioco. Lo testimoniano i risvolti di un successo sportivo che, come accaduto in passato, allarga i suoi effetti alla politica, all’economia, al sociale. Lo dimostrano le feste di piazza con gli arrampicatori di semafori in servizio permanente. E lo conferma, una volta di più, quel rito catartico collettivo che è l’inno di Mameli, cantato all’unisono prima del fischio d’inizio delle partite. I brividi, scandendo tutte le parole fino a “l’Italia chiamò”, non sono venuti solo a noi ma anche agli osservatori stranieri, colpiti dalla simbiosi tra calciatori sul prato e tifosi sugli spalti.
“Panem et circenses” sostengono i disillusi, gli scettici, i bastian contrari, suonando l’altra campana e puntando il dito contro la superficialità di un popolo distratto, individualista, che si compatta soltanto quando c’è la Nazionale, al punto che perfino Winston Churchill, in tempi non sospetti, rinfacciava agli italiani di “perdere le partite di calcio come fossero guerre e le guerre come fossero partite di calcio”.
Ma la realtà è un’altra. E’ fatta di campetti improvvisati persi tra i palazzi, di pali e traverse tenuti su a malapena, di reti strappate, di ciuffi d’erba ingialliti dal sole, di gobbe e buche sul terreno. Anche ad Arezzo ce ne sono, sparpagliati qua e là a ricordarci dove i sogni prendono il primo volo.
La realtà è fatta di sguardi innamorati davanti a un televisore, di video registrati col cellulare, di selfie sfocati e meme virali, di tifo sano, sincero, di beniamini che ti prendono il cuore, che una volta appiccicavi in camera sotto forma di poster e oggi salvi sul pc come sfondo per il desktop. E’ questa energia viscerale che spingerà un giovanotto di Castellammare di Stabia a buttarsi per terra per respingere un rigore. Come Donnarumma. O uno di Frattamaggiore a lottare contro i luoghi comuni perché considerato troppo piccolo. Come Insigne. O uno di Settignano ad allenare il piede debole per calciare forte con il destro e il sinistro. Come Chiesa. Magari ci sarà pure qualcuno, in Sardegna, che si dedicherà al calcio con così tanta forza di volontà che la mamma, per assecondarlo, lascerà l’impiego da commessa. Come accaduto a Barella. Può darsi ci sarà qualcuno, in un angolo del Sudamerica, che insieme ai genitori solcherà l’oceano al contrario per tornare a casa, dove vivevano i suoi trisnonni. Come Jorge Luiz Frello Filho, detto Jorginho. E magari ci sarà qualcuno, in Brianza, che oltre a diventare uno da Nazionale, continuerà a studiare con profitto. Come Pessina, che durante gli Europei ha pubblicato il suo diario di bordo, chiuso dopo la conquista della Coppa con frasi dolci subissate dai like: “oggi termina il più bel capitolo della mia vita fin qui. Ma non si chiuderà definitivamente, rimarrà dentro i cuori di ognuno di noi: saremo per sempre i Fratelli d’Italia di quella magica estate 2021. Da domani se ne aprirà uno nuovo. E io sarò pronto a scriverlo. Con orgoglio”.

E’ una bella parola, orgoglio. E’ per orgoglio che nella vita si cambiano tante cose, quasi tutte, ma non la squadra del cuore. E’ per orgoglio che un gol subìto ti macina l’anima e un gol segnato ti fa serrare i pugni con le vene del collo gonfie di adrenalina. Ed è sempre per orgoglio che pure oggi, da adulto, quando vedi un gruppo di ragazzini che giocano con i giubbotti ammucchiati per terra, ti viene voglia di unirti a loro.
C’è una frase bellissima del saggista argentino Jorge Louis Borges che merita di essere citata: “Ogni volta che un bambino prende a calci un pallone per strada, lì rinasce la storia del calcio”. Anche al campino di Fonterosa, prima periferia di Arezzo, con le biciclette buttate da una parte, la polvere e una maglia azzurra un po’ sdrucita.