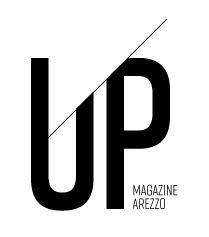La ginnastica ritmica, le Olimpiadi di Atlanta, poi la danza e il sogno di una famiglia. Storia di una donna a cui un giorno, all’improvviso, il destino ha presentato il conto, togliendole l’uso di quelle gambe che l’avevano fatta volteggiare in tutto il mondo. Storia di un’aretina che non si è arresa e ha saputo ricominciare. Volando anche più in alto di prima
Nicoletta Tinti compirà 42 anni a maggio. Ne dimostra molti di meno ma è come se ne avesse alle spalle molti di più. Ginnasta, danzatrice, tennista, ingegnere: la vita le ha cucito addosso vestiti diversi e le ha concesso più volte la gloria della ribalta e del palcoscenico. Lei, così esile e graziosa, ha sgomitato fin da quando era una ragazzina, senza l’aria da dura ma con una tenacia da fare invidia. Si è conquistata le Olimpiadi con la nazionale di ritmica a squadre, si è reinventata nella danza, ha portato a termine l’università. Poi una notte, all’improvviso, il destino le ha presentato il conto, come se tutta la leggerezza che le aveva dispensato prima dovesse essere risarcita brutalmente. Ernia dorsale D7-D8, l’intervento chirurgico, il corpo senza più sensibilità e movimento dall’ombelico in giù. Quelle gambe che l’avevano fatta volteggiare in tutto il mondo, adagiate sopra una carrozzina che lei ha ribattezzato La Gina. Per scherzarci su, per esorcizzare, per non smarrire il filo di un percorso che non si è fermato ma ha preso solo un’altra direzione.
Nicoletta, com’eri nel 2008?
Avevo quasi trent’anni, stavo per tagliare i primi traguardi. Di lì a poco mi sarei laureata, avrei messo su famiglia. Invece c’è stato questo cambiamento.
Cosa ricordi di quel giorno?
Una fitta fortissima in mezzo alle scapole. Il vomito. Il formicolio alle gambe. La difficoltà a camminare. Poi il ricovero a Siena e il responso dopo l’operazione. Quando mi svegliai, i medici mi dissero che non avrei recuperato. Tre giorni prima stavo benissimo.
Ti sei mai chiesta perché sia successo proprio a te?
No, non me lo sono chiesta. Ognuno ha la sua storia e i suoi limiti. Il mio adesso è evidente, si nota. Tante persone hanno limiti meno visibili ma più pesanti. Ho imparato che ciò che conta veramente è provare ad andare sempre un po’ più in là. Io, dopo la disabilità, ho sofferto ma ho anche vissuto esperienze bellissime, profonde.
Qual è stata la sofferenza più grande?
Ero una molto diretta, abbracci e pacche sulle spalle. Stando seduta, mi sono dovuta resettare e ho scoperto il valore del sorriso.
Oggi come ti senti: serena, inquieta, entusiasta, arrabbiata?
Mi sento affaticata per il contorno, per la pandemia che ci ha isolati. Mi mancano la condivisione, il contatto con gli altri. Dentro di me però c’è serenità: per anni sembravo una mosca senza testa, dovevo ritrovare me stessa e la mia strada. Adesso sento di avercela fatta.

Colpisce che non ci sia un filo di rancore nelle tue parole. Eppure sarebbe naturale prendersela con il mondo, maledire tutti. Come fai?
E’ vero, non mi sono incattivita, sono rimasta com’ero. Dopo l’operazione ho trascorso sei mesi all’unità spinale di Firenze per la riabilitazione. All’inizio, da sola, non riuscivo nemmeno a farmi la doccia. I fisioterapisti mi dicevano di tirare fuori tutta la rabbia che avevo dentro, ma io rabbia non l’ho mai avuta. Ho sempre pensato al presente, al futuro, mai al passato. Ogni giorno progredivo in qualcosa e mi concentravo sul passo successivo: un po’ è indole, un po’ mi ha aiutato lo sport.
E come?
Gli anni della ginnastica mi sono serviti, anni bellissimi e prosciuganti, con allenamenti duri, voglia di migliorarsi, di non arrendersi.
Anni che ti hanno portato alle Olimpiadi.
Prima a Milano con la Nazionale, quando ero giovanissima. Ad Arezzo avevo vinto la serie A con la Ginnastica Petrarca. Ci allenava Manola Rosi, un carisma pazzesco, severa in palestra e amica fuori, una donna cui devo moltissimo. In azzurro trovai un ambiente diverso, uno spirito di competizione esasperato con le mie compagne. Ma non era colpa nostra, funzionava così.
1996, giochi olimpici di Atlanta. Arrivate a un passo dalla finale nella gara a squadre, poi l’eliminazione. Cosa ti porti dietro di quei giorni?
La sensazione di disorientamento nel villaggio olimpico, in mezzo a tanti campioni famosi. Ero poco più che una bambina, mi sembrava tutto irreale, una roba più grande di me e di noi. In due minuti ci giocammo anni di rinunce, di fatica. Andò male per pochi decimi di punto.
La ginnastica ha fatto bene alla tua schiena?
Non lo so, forse no. Ma non ho rimpianti: è una disciplina che ti insegna la dedizione, la pazienza, ti dà forza e armonia.
Una disciplina che dopo Atlanta però hai lasciato.
Volevo vivere un po’ di quelle emozioni da adolescente che non mi ero mai concessa. E comunque dopo poco scoprii la danza, un’altra passione assoluta. Abbandonata solo perché, nel 2008, vedevo vicini quei traguardi di cui parlavo prima: la laurea e la famiglia. Ma è andata diversamente.
I tuoi genitori come hanno vissuto quello che tu chiami cambiamento?
Sono stati eccezionali. Né troppo presenti né troppo assenti. Mio padre, mia madre, i miei fratelli sono le mie fondamenta solide. A un certo punto guardarmi allo specchio non era piacevole, senza di loro forse non avrei resistito.
E la fede ti ha aiutato?
Diciamo che ho i miei personalissimi appigli spirituali. Mia zia Maria è mancata da pochi mesi. Era molto credente, è stata un punto di riferimento importante per me.
Nicoletta, cosa saresti oggi senza quella fitta alla schiena?
Sarei comunque un ingegnere ma non avrei ricominciato con la danza. Poi avrei una famiglia e tre figli. Ecco, all’elenco delle sofferenze possiamo aggiungere gli affetti. Ne ho persi di importanti, comprese alcune amiche che si sono allontanate da me.
Come hai ricominciato dopo?
Giocando a tennis. Cinque anni in cui ho riscoperto il sano piacere della fatica. Ho partecipato a tornei in Italia e all’estero, ho superato gli esami per la nuova patente di guida, mi sono riguadagnata l’indipendenza. Con la mia Golf ho viaggiato per oltre 300mila chilometri, spostarmi da sola è stata una liberazione.
Mai avuto paura di non farcela a superare l’ostacolo?
A volte sì ma è durata poco. Sono stata anche fortunata nell’incontrare persone che mi hanno dato una grande mano.

Per esempio?
Keith Ferrone, il coreografo della compagnia di danza di Firenze dove ero stata per dieci anni. Nel 2014 mi feci coraggio e tornai lì, un po’ per curiosità e un po’ per nostalgia. Lui mi vide, mi abbracciò con un trasporto incredibile, mi sollevò dalla carrozzina. Ho i brividi anche ora a ripensarci. Keith ha insistito a lungo perché tornassi a danzare, nonostante tutto. E io mi sono lasciata convincere volentieri. Poi ho conosciuto Silvia Bertoluzza. Mi aveva sostituito alla compagnia quando io abbandonai, tra di noi è nata un’amicizia profonda. E’ una ragazza solare, positiva, piena di idee, mi ha aiutato a scrollarmi di dosso tante indecisioni.
Voi due danzate insieme: tu il busto e lei le gambe. Sembra la metafora del vostro rapporto, del vostro legame. E’ veramente così?
Sì, è la testimonianza del fatto che la condivisione è fondamentale, che camminando da soli si va più veloci ma camminando insieme si va più lontano. Danziamo con la compagnia InOltre che abbiamo fondato a Bologna. Siamo in quattro a ballare, con cinque musicisti. Da qualche anno inoltre insegno danza alla scuola Arte Danza, sempre a Bologna.
Il vostro spettacolo è sospeso a causa della pandemia. Quanto ti manca?
Moltissimo. Io non ero troppo convinta all’inizio, con Silvia dovevamo armonizzare i movimenti, fonderci insieme. Non è stato sempre facile, abbiamo provato e riprovato e riprovato, fino a quando siamo state pronte. Ci siamo esibite in tutta Italia, abbiamo partecipato a Italia’s Got Talent, danzato davanti a Papa Francesco. A settembre del 2014, quando sono tornata sul palco in piazza del Carmine, a Firenze, ho capito che avevo veramente voltato pagina. Che la mia vita aveva ancora un senso. Poi Silvia mi ha fatto anche una sorpresa.
Quale?
Un giorno mi ha portato a Castel Bolognese dai Grementieri, una famiglia di fabbri. Senza dirmi niente, avevano preparato una struttura in metallo che mi consente di danzare in piedi. Si chiama Grim, è un carrello con sei ruote. L’emozione di abbracciare qualcuno in posizione eretta, ritrovando equilibri e visuali che avevo perso, è stata scioccante, meravigliosa.
C’è un lato del tuo carattere in cui ti senti diversa dopo quello che ti è successo?
No, è cambiato soprattutto lo sguardo della gente. Percepisco sempre un filo d’imbarazzo negli altri, specie al primo approccio. Ma non ci faccio caso. Se c’è qualcosa in cui sono cambiata è la pazienza: adesso ne ho molta di più. E ho imparato ad affidarmi agli altri.
Che rapporto hai con la tua sedia?
All’inizio è stata dura. Mi svegliavo la mattina, la vedevo lì accanto al letto. Tante volte ho sperato che fosse un sogno, che potesse scomparire con un battito di ciglia. Poi ho imparato a conviverci, la carrozzina è fondamentale per me. Tra un mesetto ne arriverà una nuova, questa comincia a perdere colpi per l’usura.
Cosa significa essere disabili?
Significa avere la responsabilità di testimoniare agli altri che la vita va vissuta. Ho sempre avvertito il dovere e la necessità di parlare, di far capire e infatti ogni anno partecipo a camp estivi organizzati dall’associazione sportiva Freerider di Varese, dedicati a ragazzi affetti da spina bifida. Vado nelle scuole per incontrare i bambini. I primi tempi facevo fatica perfino a vestirmi, quindi posso spiegare in modo credibile che bisogna sudare, impegnarsi, prendere coscienza dei nostri limiti e lavorare per superarli, capire i limiti degli altri e dare loro un aiuto. Interagire con i bambini mi dà grande gioia. Poi c’è dell’altro.

Cioè?
Disabilità significa pure rinunciare a entrare in un negozio perché c’è uno scalino troppo alto. O non trovare parcheggio perché il posto riservato è occupato dal furbetto di turno. Io però cerco di non arrabbiarmi troppo, di prenderla con filosofia.
Fin qui abbiamo parlato di Nicoletta. Dell’ingegner Tinti invece che ci dici?
Che fin da piccola volevo diventare ingegnere civile. Ce l’ho fatta e ne sono orgogliosa. Svolgo la libera professione, collaboro da tanto tempo con lo studio Becucci di Arezzo. Sono innamorata di questo lavoro.
Hai vissuto a Milano, a Firenze, a Bologna. Arezzo che ruolo ha recitato nella tua vita?
E’ la mia città, è qui che ho messo le basi per quella che sono oggi. E’ vero che ho vissuto altrove, ma da Arezzo non sono mai scappata. Come è vero che sono tornata in un momento molto complicato per me e che, per certi aspetti, l’ho subìto come una forzatura. Però mi sento aretina nel profondo, soprattutto per l’inclinazione che ho a condividere emozioni ed esperienze.
Come dobbiamo considerarti oggi: una ex ginnasta, una danzatrice, un’ingegnere? O qualcos’altro?
Quando cresci nello sport, una ex atleta non ti senti mai. Ho sempre avuto bisogno di quell’adrenalina e quindi mi definisco una sportiva anche oggi.
Nicoletta, hai un sogno da realizzare, un progetto da completare in questa tua vita così densa?
A me piace ascoltare storie che trasmettono un insegnamento. E quindi sì, un progetto ce l’ho: inventarmi un posto dove ci si può raccontare, sia dal punto di vista artistico che umano. Un teatro speciale, un luogo dove chiunque abbia qualcosa da dire, possa farlo davanti a un pubblico interessato e scambiarsi un po’ di felicità.
La felicità. Tu hai capito cos’è veramente?
Ho capito che ognuno di noi, improvvisamente, si trova davanti a uno specchio. E che dietro c’è un mondo intero, una vita che aspetta la nostra nuova essenza. La felicità è saltare dietro quello specchio.