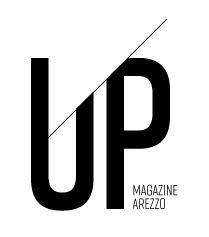Tiziana Metitieri è un’eccellenza aretina. E come molte eccellenze aretine si nasconde nel cuore della città, a due passi da piazza Grande. Radici salernitane, natali svizzeri, è ad Arezzo che Tiziana ha trovato il suo buen retiro, anche se il lavoro la porta tutti i giorni a Firenze, nel dipartimento di clinica neurologica pediatrica dell’ospedale pediatrico Meyer. Pendolare per necessità, con tutti i problemi del caso, ben radicata per convinzione, quella che in questi anni l’ha portata ha combattere la disinformazione scientifica, che si nasconde dappertutto e non riguarda esclusivamente la pandemia di Covid-19, che tra un po’ festeggerà, amaramente, il suo anno di vita, se così la possiamo chiamare. Laureata in psicologia, con un’esperienza ultraventennale, ha conseguito un dottorato in neuropsicologia e a Firenze svolge anche la libera professione. Nel 2014 ha aperto un blog, neuropsicolab.blogspot.com, ha pubblicato su alcune riviste scientifiche e scrive per valigiablu.it, queryonline.it e iltascabile.com. I temi? Tre principalmente: neuropsicologia, informazione e disinformazione scientifica, la parità di genere nelle scienze e dintorni.
Qual è il suo ruolo all’interno del dipartimento di clinica neurologica pediatrica dell’ospedale pediatrico Meyer, diretto dal professor Guerrini?
Sono una psicologa e coordino le attività dell’ambulatorio di neuropsicologia clinica. Siamo in quattro e lavoriamo in stretta relazione con i nostri neurologi e neuropsichiatri infantili.
In cosa consiste il suo lavoro?
Consiste nel fare diagnosi sulle alterazioni dello sviluppo e acquisite dei bambini e degli adolescenti, sia cognitive che psicomotorie, dalle difficoltà del linguaggio a quelle della coordinazione. Generalmente arrivano al Meyer su indicazione dei pediatri e degli specialisti del nostro reparto. A quel punto spetta a noi raccogliere tutta una serie di informazioni attraverso dei test e degli strumenti di osservazione che ci permettono di fare una diagnosi neuropsicologica, diagnosi condivise dalla comunità scientifica. Possono avere epilessia, sindromi genetiche, metaboliche e sta a noi capirne il profilo cognitivo comportamentale associato. A volte, per esempio, può trattarsi di un’epilessia benigna che col tempo va in remissione, altre invece una malformazione o un tumore al cervello sul quale poi è necessario intervenire chirurgicamente e noi effettuiamo le valutazioni pre e post chirurgiche. Fare diagnosi è fondamentale per comprendere come procedere, quale tipo di riabilitazione mettere in atto, quali indicazioni dare alle famiglie e alla scuola. Altre ancora, nei casi di dislessia e discalculia, lì indirizziamo quanto prima a interventi di potenziamento e se è il caso dal logopedista. Prima capiamo bene qual è il disturbo di cui soffrono, prima possiamo intervenire e cercare di risolverlo o di inserirlo in un percorso riabilitativo.
Cos’è un’etichetta?
L’etichetta diagnostica non è uno stigma, ma è un elemento fondamentale che ci aiuta a inquadrare meglio il profilo, le difficoltà e, quindi, il da farsi. Se sono necessari ulteriori approfondimenti diagnostici, quali trattamenti riabilitativi, comprendere come adattare tutto questo al contesto scolastico e familiare. L’etichetta ci permette di scegliere la giusta cassetta degli attrezzi, rispetto ai disturbi che hanno colpito il bambino o l’adolescente. Una volta confermato il disturbo, infatti, la famiglia può avviare l’iter per il riconoscimento della legge 104, che a sua volta permette di richiedere l’insegnante di sostegno, uno specifico percorso riabilitativo presso i servizi territoriali, i permessi per i genitori. Generalmente queste difficoltà sono state già rilevate in famiglia prima di arrivare a noi, che con la diagnosi possiamo definirle, dare loro un nome e procedere di conseguenza, confrontandoci con altri specialisti. La mancanza di un’etichetta può acuire la distanza tra il bambino e i suoi coetanei e al tempo stesso non deve essere discriminante, ne deve anzi permettere e facilitare l’integrazione. Non riconoscere certe difficoltà, non avere la diagnosi, può complicare il quadro, aumentare il disagio del minore nell’apprendimento e nella socializzazione, fino ad arrivare a un regresso.
È difficile distinguere i disturbi cognitivi genetici da quelli di contesto?
Non è mai un solo elemento o un solo parametro che ci permette di fare la diagnosi. Non possiamo attribuire una diagnosi con un solo test, abbiamo bisogno di osservare molti aspetti prima di essere sicuri del disturbo che il bambino presenta. I disturbi dell’ansia, che si manifestano, per esempio, anche con difficoltà di attenzione, possono essere inizialmente fraintesi, ma al vaglio di prove specifiche si evidenziano con nettezza. I disturbi cognitivi di contesto, invece, sono il frutto di una deprivazione, un bambino non esposto a una serie di stimoli, situazione che, ad esempio, provoca una povertà di vocabolario e quindi di linguaggio. Per capire quali ne siano le cause bisogna conoscere la storia familiare, studiare con attenzione e vedere se cambiando il contesto cambiano le condizioni del bambino e vengono meno certe difficoltà. In questi casi lasciamo in sospeso la diagnosi, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Quanto è complicato per un genitore accettare che il proprio figlio abbia dei disturbi cognitivi? Quali sono le reazioni più comuni?
Dipende da chi sono i genitori e dalla loro storia, singola e insieme, dalla loro relazione insomma. Generalmente se arrivano a noi vuole dire che il bambino mostrava già delle difficoltà a casa e a scuola. Quindi, spesso, una diagnosi di disturbo cognitivo provoca sollievo, perché aiuta a capire il problema, come intervenire, come essere d’aiuto. Una diagnosi aiuta ad avere una strada definita, un sentiero da seguire, invece che girare a vuoto. E per una famiglia è molto importante. A volte, anche se in minima parte, c’è il rifiuto ad accettarla e ad attivare misure di tutela per il minore, con la richiesta di vedere altri specialisti, alla quale noi aderiamo indicandoglieli. Nel primo caso seguiamo la famiglia, cioè una volta fatta la diagnosi programmiamo dei controlli oppure inviamo ai servizi territoriali, cercando di essere di supporto per un’educazione sul problema specifico, cosa comporta per il minore, quali diritti devono aspettarsi. Ci deve essere tutta intorno alla famiglia una rete che comprende pure l’assistente sociale, quando necessario.

In questi mesi si parla molto delle difficoltà dei minori ad affrontare pandemia e lockdown ripetuti. C’è al riguardo pure una narrativa mediatica piuttosto ansiogena. Qual è la vostra esperienza al Meyer?
Il carico psicologico di questo periodo colpisce tutti, dal bambino all’adulto, da questo all’anziano. Ce lo ricorderemo e si stempererà piano piano quando usciremo da questo incubo. Però andrebbe bandita la parola allarme, anche perché quando è così generalizzato rischia di nascondere chi sta soffrendo veramente. Il rischio, poi, è che proprio i soggetti più vulnerabili ne subiscano le conseguenze, perché sono ancora più vulnerabili adesso e lasciarli indietro potrebbe voler dire annullare i benefici di tutto il percorso di riabilitazione fatto sino a ora. Gli adolescenti che già erano ai margini prima lo saranno ancora di più e svilupperanno ulteriori sintomi di disagio mentre quelli che hanno intorno un contesto che li aiuta, ovviamente, hanno retto meglio il carico psicologico. Un esempio è la didattica a distanza senza strumenti. Molti adolescenti stanno abbandonando la scuola e continuando a generalizzare e ad allarmare ci (li) stiamo perdendo, quando dovremmo capire meglio cosa fare, dove e con chi.
Alcune scuole hanno messo a disposizione dei ragazzi lo psicologo. Dal suo punto di vista è un’azione corretta?
Sì, assolutamente sì. È accaduto in pochissime scuole, a dire la verità, ma dove lo hanno fatto gli adolescenti sono stati e sono aiutati ad affrontare questa situazione.

Spesso si legge che la tecnologia isola i ragazzi. In questo periodo storico, però, è corretto affermare che i minori soffrono meno l’isolamento proprio grazie a questa?
Nella fase del primo lockdown c’è stata una generale consapevolezza e apertura verso la tecnologia, non solo per gli adolescenti, ma pure per adulti e anziani, consapevolezza che ha spinto verso un accesso più ampio. Non c’è stato, però, il cambio di mentalità e in generale c’è una visione adultomorfa, che continua a stigmatizzare le nuove tecnologie, visione che si è ripetuta nei decenni e, direi, anche nei secoli. C’è una visione distorta che non corrisponde alla realtà. Se andiamo a vedere attentamente gli adolescenti utilizzano le nuove tecnologie per scopi diversi, dallo studio al divertimento, alla socializzazione. La differenza è se questi sono soggetti attivi o passivi, cioè se semplicemente scrollano la timeline per vedere cosa fanno gli altri, senza alcuna interazione. Molti adulti si concentrano sulla quantità, il tempo trascorso sui cellulari, ad esempio, ma è la qualità, cioè il come che fa la differenza. Gli adulti hanno paura a conoscere quello che fanno i propri figli, invece bisogna informarsi, stabilire dei ponti con loro, interrogarli senza giudizi o divieti, che spesso è la strada più facile. Chiedere cosa fanno i propri figli quando stanno da soli è già un primo fattore di protezione, che può aiutare a prevenire pericoli e disagi. Il genitore deve allertarsi quando la tecnologia diventa un rifugio, quando manca l’interazione con i coetanei, perché, ripeto, non è il tempo che stabilisce una dipendenza. E questo vale pure per i videogiochi.
La pandemia ha, di fatto, portato alla luce tutte le fragilità del giornalismo medico e scientifico italiano, fragilità che esistevano anche prima. Da dove nascono e come è possibile ‘curarle’?
A freddo è giusto ricordare che siamo stati messi, tutti, di fronte a una situazione completamente nuova, che evolveva in continuazione. Le incertezze e le dispute sono state fondamentali dal punto di vista scientifico per permettere di arrivare a delle conclusioni. Il confronto tra ipotesi diverse è stato un beneficio per la scienza che nel giro di nemmeno dodici mesi ha prodotto vaccini e nuove cure come gli anticorpi monoclonali. In scienza il confronto è sempre un arricchimento. Poi è arrivata la politica e gli scienziati hanno avuto un palcoscenico perché dovevano avere un impatto politico sull’opinione pubblica, scatenando pro e contro rispetto a certe misure, dettati da interessi e schieramenti politici, ed economici, diversi. Tutto questo riportato senza filtro ha ingenerato molta confusione e amplificato i contrasti e le polarizzazioni. Amplificato ancora di più da una comunicazione che ha deciso di aggiornarci più volte al giorno, in modo contrastante, sulla pandemia di Covid-19. La conoscenza e la comunicazione scientifica hanno conosciuto, così, una dimensione corrotta.

L’informazione, o disinformazione, scientifica sembra avere come target principali gli adolescenti. Perché?
Direi che è dedicata un po’ a tutti, ma spesso si concentra sulle categorie sociali più responsive, cioè quelle che reagiscono in maniera più ansiosa all’incertezza. Quindi bambini, adolescenti e per estensione i genitori. Il tutto condito dall’attenzione politica verso la scuola, in quel delicato equilibrio tra contenimento del virus e necessità didattiche, ancorché sociali dei ragazzi. Già a marzo scorso gli specialisti avevano tracciato delle linee guida per prevenire il disagio dei minori di fronte all’impatto del lockdown, ma ci si è concentrati su altro, disattendendo ogni indicazione e oggi siamo al calcolo dei danni. Io ritengo che la scuola, in quanto istituzione, ne sia uscita e ne stia uscendo con grande dignità se si pensa a come era messa prima del Coronavirus, con pochissime risorse, sia strutturali che umane, facendo un lavoro enorme. Si è deciso, invece, di trasformala in terreno di scontro politico, sociale e, di conseguenza, economico, senza pensare realmente alle sue necessità. Contemporaneamente c’è stato un accanimento verso gli adolescenti, il solito accanimento generazionale, una guerra che si combatte, al solito, sopra le loro teste, senza coinvolgerli, senza avere un rapporto maturo con loro, senza ascoltarli.
Da anni con il suo blog, neuropsicolab.blogspot.com, combatte la disinformazione scientifica. Perché ha scelto di farlo e come procede la battaglia?
Il mio piccolo blog è nato per svago, per scrivere sugli argomenti di cui mi occupo quotidianamente. Ho cercato di presentare una lettura critica delle neuroscienze e della psicologia, dalla metodologia ai risultati, alla comunicazione degli stessi, perché l’errore può avvenire a ogni livello. Spesso vengono esaltati dai media dei risultati scientifici con evidenti punti deboli strutturali, piuttosto che approcciarsi con una lettura critica. La scienza ha dei limiti, gli scienziati non sono uomini al di sopra degli altri, per questo è necessario avere un fact-checking sul loro lavoro, fact-checking che non può fare chiunque, ovviamente, ma persone altrettanto preparate. Il problema è che poi dietro certi studi e dietro certi risultati ci sono gli uffici stampa di enti e aziende che cercano di presentarli come rivoluzionari, la dimensione corrotta di cui sopra. È necessario il confronto continuo tra scienziati e specialisti e se viene segnalato un errore non reagire come se fosse stato commesso un reato di lesa maestà.

Un altro tormentone che riguarda gli adolescenti è quello sulla pericolosità, fisiologica e psicologica, dell’utilizzo e della fruizione dei social media lungo tutto l’arco della giornata; il male assoluto per i minori ad ascoltare i media mainstream. Cosa c’è di vero, cioè di scientificamente dimostrato?
Questo panico è continuamente alimentato da passati studi scientifici che si sono rivelati deboli dal punto di vista metodologico. Con ricercatori che avevano enormi pregiudizi sulla materia, pregiudizi insiti nelle domande: telefonini, videogiochi e social media fanno male? Quanto fanno male? Mi pare evidente che queste sono domande distorte e pregiudizievoli per tutto il seguente lavoro scientifico. In uno studio del genere lo scienziato si deve aspettare effetti negativi, positivi o neutri, ma gran parte della ricerca è stata condizionato fino a tutto il 2020. Debole il metodo e a volte anche il numero esiguo dei soggetti studiati. Il solito esempio del tempo di esposizione, in 10 minuti posso bullizzare un compagno di classe, un collega, posso inviare video violenti, mentre in 4 ore consecutive posso studiare e interagire con i miei amici. I parametri e le scale cliniche utilizzati per questi studi sono devianti e poco attendibili. D’altra parte, alcuni studi sui videogiochi, per esempio, hanno evidenziato che quel tipo di attività può aiutare l’adolescente a superare stati di angoscia, ansia o depressione. Sappiamo che un ragazzo difficilmente chiede aiuto ai genitori, più facilmente ai coetanei, per questo abbiamo bisogno di domande diverse e nuovi strumenti per approfondire questi studi e raccogliere dati realmente oggettivi.
Perché, per esempio, sull’utilizzo dei social media da parte dei minori non si parla mai della formazione dei loro adulti?
Perché scatenare il panico con la paura è più semplice, le risposte sono più rapide, sbagliate ma rapide, e nessuno si deve formare o impegnare a conoscere strumenti e ambienti digitali dei quali spesso ignora funzionamento e funzionalità. Gli adulti, invece, si devono assumere la responsabilità di parlare con i ragazzi, di confrontarsi con loro, con il giusto atteggiamento e le giuste domande. Si devono creare dei ponti e mantenerli nel tempo, per non perdere mai quel filo che unisce le due generazioni. Tutto questo si fa e si riesce a farlo quando si è consapevoli e a conoscenza dell’argomento. Il dialogo è la strada giusta, la paura e il divieto quelle veloci.

Il giornalista Mario Tedeschini Lalli ha affermato che Internet non è solo uno strumento ma è diventato il luogo della nostra vita, anche relazionale. Cosa ne pensa?
È così per tutti. Nessuno, oggi, può prescindere da mail, chat, Google e social, qualunque sia la nostra condizione sociale, il nostro lavoro e il posto in cui viviamo. Senza Internet saremmo dei cittadini esclusi, con minori diritti, penso alle famiglie e ai paesi isolati e senza un collegamento alla Rete durante il primo lockdown. Fuori dal mondo, fuori dalla sanità, fuori dall’educazione. Internet è tutto questo e anche molto di più, è uno strumento fondamentale per la nostra esistenza, per esercitare tutti i diritti di un cittadino del terzo millennio.
Riguardo al giornalismo medico e scientifico non sarebbe meglio affidarlo a dei tecnici che hanno elevate abilità di comunicazione, sia scritta che orale, o si rischia di cadere nei tecnicismi?
In questo periodo si è sentita forte la mancanza dei giornalisti scientifici nelle varie redazioni, giornalisti che avrebbero potuto (dovuto) fare da fulcro e mediazione insieme; una mancanza gravissima a mio avviso. Sarebbe stato fondamentale, soprattutto, nei dibattiti scientifici, ma qui entriamo nella condizione e nella tutela della sua professione, che talvolta non permette di esporsi in modo critico. La scienza si evolve, cambia continuamente, c’è quindi necessità di giornalisti che sappiano comunicarla, accertandosi delle rispettive validazioni e se si commette un errore avere la capacità e la dignità di affermarlo, chiedere scusa e ripartire. Il contrario mi pare che sia sotto gli occhi di tutti.

Tornando agli adolescenti, come giudica l’idea del governo di utilizzare degli influencer per comunicare con loro?
L’ho trovata un’ottima scelta. Gli adolescenti, per le loro caratteristiche evolutive, tendono a ribellarsi a imposizioni e divieti, soprattutto quando vengono da adulti, famiglia e scuola. Gli influencer, in questo caso, diventano dei mediatori, sono i loro idoli, parlano la stessa lingua, sono ascoltati, quindi chi meglio di loro può parlare ai ragazzi e alle ragazze su mascherina, assembramenti, ecc.
Pure alcuni medici, sui social, sono diventati influencer. La ritiene una scelta strategicamente corretta per la comunità, scientifica e non?
Ritengo che questo approccio porti a una maggiore diffusione della conoscenza scientifica e ricordiamo che, da questo punto di vista, in Italia siamo messi malissimo. Anche loro, però, sono fallibili, poiché l’errore fa parte del processo scientifico. Va accettato, spiegato e comunicato. Ci sono stati dei premi Nobel che hanno commesso errori clamorosi, mettendo a rischio la salute delle persone durante la pandemia. Per questo ci vuole una lettura critica, per comprendere l’errore, come nasce, stimolando la discussione e la ricerca scientifica.

Cosa possiamo e cosa dobbiamo fare per i nostri ragazzi?
Parlare con loro e non sopra di loro. Mettersi di fronte cercando di capirli e farsi capire, facciamogli delle domande diverse e forse avremo delle risposte nuove. Devono sapere su chi contare quando sono in difficoltà e a volte i coetanei possono vedere più e meglio dei genitori e magari aiutarsi gli uni con gli altri, avendo sempre degli adulti come punto di riferimento.
La pandemia ci ha messo di fronte a paure e fragilità varie, ognuno per il suo. Adolescenti e adulti che si sentono in difficoltà a chi si possono rivolgere?
Stiamo affrontando tutti un periodo difficile. Ansia, eccessiva reattività e insonnia sono sintomi comuni a età diverse. Molti di questi si riassorbiranno col tempo quando saremo usciti da questo incubo. Per adesso dobbiamo cercare di trovare qualcosa da fare che ci faccia stare bene e che ci rilassi. Poi, nei casi più complessi, c’è il medico di fiducia che può indirizzarci verso lo psicologo o i servizi territoriali del sistema sanitario e lì dove questi mancano rivolgersi ad associazioni locali o specialisti privati. Evitiamo, in modo particolare, gocce miracolose, integratori e simili per prendere delle scorciatoie che scorciatoie non sono, anzi.
Cosa ci dobbiamo augurare come comunità per il futuro, in generale, e cosa possiamo fare per esigere una migliore informazione medico-scientifica?
Possiamo augurarci di ricordare quello che stiamo passando e non riprendere come se non fosse accaduto niente, come se il mondo potesse ricominciare da dove lo avevamo lasciato prima della pandemia. Nonostante le difficoltà è sorto un nuovo senso di comunità, sia dentro determinate categorie professionali, come quelle degli operatori sanitari, che tra queste e la popolazione. Servirà costruire una memoria collettiva, cercando di elaborare i traumi e onorare le persone che sono morte, ricordarle rafforzerà ancora di più le singole comunità. Consapevoli che da soli non si superano le crisi. E dovremo pretendere una migliore cultura e informazione scientifica, accettando l’errore ed evitando schieramenti tutti contro tutti. Più equilibrio e meno disinformazione.